
13 Dic Violenza contro le donne
La violenza contro le donne. Il femminicidio. La legislazione e la prassi sulle violenze di genere.
1. Violenza contro le donne e violenza di genere.
La violenza contro le donne è una forma di violenza basata sul genere.
E’ stata riconosciuta, dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, come una violazione dei diritti fondamentali della donna ed è annoverata tra le violazioni dei diritti umani.
Molto spesso, per definire la violenza contro le donne, si utilizza l’espressione “violenza di genere”.
Tale espressione, introdotta dalla Direttiva 2012/29/UE (cui in Italia è stata data recente attuazione con il d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212), costituisce uno strumento di unificazione legislativa, valido per tutte le vittime di reato.
In particolare, la violenza di genere, è stata definita come: “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di essere umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d’onore”.
A livello internazionale, è stato riconosciuto ed affermato il carattere universale e la natura strutturale del fenomeno della violenza contro le donne per motivi di genere. La definizione più diffusa di tale fenomeno, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, è quella che include: qualunque forma di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, istituzionale e ogni altra forma di violenza che incida sull’integrità, dignità e libertà delle donne), che può manifestarsi in diversi luoghi e tipi di relazione, riconducibili tanto alla dimensione privata quanto a quella pubblica, esercitata nei confronti della donna “perché donna”.
Nel panorama complesso della violenza di genere esiste, dunque, uno stretto e significativo rapporto tra discriminazione e violenza contro le donne.
Nello scenario europeo, ha assunto un rilievo particolarmente significativo la Convenzione di Instanbul del 2011 che, all’art. 3, descrive tre diverse tipologie di violenza: la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la violenza di genere. Queste tre diverse forme di violenza sono tutte accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica, all’interno di un più generale concetto di violenza, da cui discende una nozione di vittima riferita a qualsiasi persona fisica che la subisca.
L’aspetto più significativo della Convenzione di Instanbul (ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 giugno 2013, n. 77), è stato il riconoscimento della violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e come uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e dell’emancipazione femminile.
2. La l. n. 119/2013, c.d. legge sul femminicidio e l’effettiva portata del fenomeno della violenza sulle donne.
Alla ratifica della Convenzione di Instanbul, da parte dell’Italia, ha fatto seguito il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifiche, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, c.d. “legge sul femminicidio”. Questa legge, ha introdotto nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure preventive e repressive, volte a combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme.
Le più diffuse forme di violenza sulle donne sono: la violenza domestica; la pedofilia; la tratta; le mutilazioni genitali e lo stupro di guerra.
L’espressione violenza domestica, fa riferimento alla violenza che si esplica nella sfera familiare e, più in generale, affettiva (quindi non solo nell’ambito della famiglia intesa in senso stretto). Essa si caratterizza per l’esistenza di una relazione, familiare o affettiva, tra autore del reato e vittima (di cui spesso l’autore del reato è partner intimo) o di una relazione tra vittima ed altro membro del gruppo familiare. Questo tipo di violenza, ha da sempre costituito un tabù socio-culturale ed è, tuttora, difficile da accertare, in considerazione anche della riluttanza delle vittime a denunciarla. Ciò comporta che il fenomeno della violenza domestica sia un fenomeno sommerso, difficile da perseguire penalmente.
La nozione di violenza domestica ha avuto riconoscimento giuridico per effetto dell’art. 3, co. 1, del d.l. 93/2013, che ha stabilito che tale forma di violenza è riferibile “a uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la residenza con la vittima”.
L’intervento d’urgenza del Governo, che ha definito la violenza maschile sulle donne una vera e propria emergenza sociale (introducendo misure che aggravano o estendono la risposta sanzionatoria in relazione ai reati di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking), ha posto però l’accento, più sulla natura contingente del fenomeno che su quella sistemica e strutturale. Infatti, il ricorso alla decretazione d’urgenza, in materia di violenza contro le donne, è stato dettato, principalmente, da una recrudescenza della violenza maschile sulle donne. In realtà, va rilevato che tale recrudescenza è solo presunta, perché in Italia, non esiste ancora una raccolta ufficiale dei dati sugli omicidi disaggregati per genere, così come non esistono dati statistici ufficiali, concernenti il numero dei processi penali instaurati per i casi di violenza maschile sulle donne. Questa circostanza impedisce di misurare accuratamente l’effettiva portata del fenomeno in oggetto.
Ad ogni modo, le ricerche compiute, in oltre un decennio, hanno dimostrato che la violenza contro le donne è endemica, tanto nei paesi industrializzati quanto in quelli in via di sviluppo. Tale fenomeno, infatti, è legato al ruolo che tradizionalmente è riconosciuto alla donna nella società e nella cultura a dominanza maschile, sia dentro che fuori le mura domestiche, per ragioni di ordine storico, sociale o culturale.
La violenza di genere, quindi, non è solo un fenomeno sociale, legato a ruoli e comportamenti che la società stabilisce per i due sessi, ma è anche un fenomeno culturale, in forza del quale il sesso femminile è uno dei fattori socio-ambientali, che possono dar luogo ad una predisposizione specifica delle donne a subire certe aggressioni e a diventare soggetti passivi di certi reati. La differenza di genere è quella determinata dalle convenzioni e dalle dinamiche socio-culturali e designa: i ruoli socialmente e politicamente costruiti (che una data società ritiene appropriati per le donne e gli uomini) sui quali si fonda l’integrale distribuzione del potere; la posizione di subalternità delle donne, che rende possibile il mantenimento della posizione di dominio maschile e le conseguenti discriminazioni tra i sessi.
3. Le origini del termine femminicidio.
Nel linguaggio corrente è in uso, da qualche tempo, il termine femminicidio, utilizzato nel dibattito sociale e politico per indicare la violenza maschile sulle donne per motivi di genere, in riferimento: ad eventi non episodici collegati con i ruoli sociali che l’uomo o la società vorrebbe imporre alle donne; a fatti strutturali e sistemici che, pur in forme diverse di oppressione e di violenza apparentemente separate, sono caratterizzati da elementi e motivazioni comuni.
Il termine femminicidio è entrato nell’uso corrente a partire dai lavori della sociologa e criminologa statunitense Diana Russell e dell’antropologa messicana Marcela Lagarde.
La Lagarde, in particolare, è stata una delle prime teoriche del concetto di femminicidio (femmina + omicidio) con una connotazione sociale, culturale e politica. Ella ha utilizzato questo termine: per rivolgersi ad un vasto pubblico e raggiungere, soprattutto, le donne; per indagare e ricordare un caso eclatante di violazione dei diritti umani delle donne, assunto come emblema a livello mondiale del fenomeno, ma anche dell’impotenza istituzionale e della complicità culturale maschile nel dramma del femminicidio. Si fa riferimento ai femminicidi di Ciudad Juárez, città ai confini tra il Messico e gli Stati Uniti, dove, nel corso degli anni, nella totale inattività del Governo, sono state uccise numerosissime giovani studentesse e donne, provenienti dalle periferie impoverite, che lavoravano nelle maquiladoras (stabilimenti di assemblaggio e lavorazione di materie prime) o in altri settori dell’economia informale.
Questa vicenda, portata all’attenzione globale, fece sì che il termine femminicidio entrasse nel dibattito politico e giuridico internazionale per indicare la sistematicità della violenza maschile, come problema strutturale e come forma di punizione e di controllo sociale sulle donne. Gli organismi internazionali di difesa dei diritti umani delle donne, tuttavia, hanno tradotto la categoria criminologica e sociologica del femminicidio, nel più ampio alveo del concetto di violenza di genere, per racchiudere in un solo termine tutte quelle forme di violenza (sociali, economiche, istituzionali) commesse sulla donna, volte al suo annientamento fisico o psicologico che, non necessariamente, si concludono con la morte della donna.
Per tale ragione, il termine femminicidio, pur avendo una diffusione globale, è quasi del tutto estraneo alle fonti europee e a quelle internazionali che, nel settore della prevenzione e repressione di pratiche violente esercitate contro le donne, hanno prevalentemente utilizzato l’espressione “violenza di genere”. In campo criminologico, la categoria concettuale del “femminicidio”, si riferisce: non soltanto all’appartenenza delle vittima al sesso femminile ed all’eliminazione fisica della donna (forma estrema di violenza di genere contro le donne), ma anche (con un ampliamento del suo significato originario) ad ogni forma di violenza e discriminazione esercitata dall’uomo sulla donna in quanto donna (motivata dalla volontà di dominio, di possesso, di controllo dell’aggressore sulla vita della vittima), tale da provocarle sofferenza fisica o psicologica, fino all’annientamento fisico o psichico della personalità femminile, tanto in ambito privato quanto nella socialità e nella partecipazione alla vita pubblica. Si tratta, dunque, di un concetto molto ampio che esprime la matrice comune di ogni forma di violenza contro le donne e che contiene in sé il concetto culturale di violenza di genere, socialmente favorita, se non anche accettata e giustificata.
Sotto l’aspetto criminologico, perciò, la parola femminicidio (definita in origine con la parola femicidio) è orientata non solo verso la vittima ovvero la donna, ma anche verso l’autore delle violenze ovvero l’uomo e contiene al proprio interno due significati non sovrapponibili e per certi versi contrastanti. Da una parte, infatti, con la parola femminicidio si fa riferimento alla totalità degli atti di violenza maschile sulle donne, mentre dall’altra si fa riferimento all’uccisione di una donna da parte di un uomo, con un movente di genere. In quest’ultima accezione, il femminicidio non è più la violenza contro le donne in tutte le sue forme, ma soltanto una delle sue estreme conseguenze ovvero l’omicidio di una donna commesso da un uomo.
Non è solo il sesso, ovvero il genere femminile della vittima, o il dato oggettivo di una relazione sentimentale tra autore e vittima a caratterizzare il femminicidio, poiché non tutti gli omicidi dolosi in cui la vittima è una donna rientrano nella predetta categoria, ma solamente quelli in cui la donna, in stretta relazione sentimentale con il suo assassino, sia stata uccisa per una motivazione di genere o per il fatto di essere donna, indipendentemente dall’esistenza di un pregresso rapporto relazionale con l’autore del reato.
4. La violenza contro le donne nel codice penale italiano. Assetto passato e presente.
In passato, alcune norme del codice Rocco (ed ancor prima del codice Zanardelli) – retaggio di un’epoca anacronistica ed oggi giuridicamente insostenibili – si sono ispirate ad una concezione etico-culturale di una famiglia, improntata a criteri di disuguaglianza fra i coniugi e a rigidi schemi di tipo patriarcale, caratterizzati da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell’uomo ed in cui la famiglia rappresenta il primo luogo di organizzazione del potere maschile sulle donne e l’istituto per eccellenza dove si definisce la subordinazione femminile.
Le norme cui si fa riferimento – che attraverso il diritto penale, legittimavano un sistema sociale fortemente discriminatorio nei confronti delle donne – sono rimaste in vigore fino a qualche decennio addietro e tra di esse, con riguardo alle fattispecie criminose che si sviluppano in ambito familiare, a titolo esemplificativo, possono essere menzionate:
1. art. 559 c.p.: che prevedeva la punizione del solo adulterio da parte della moglie;
2. art. 560 c.p.: che puniva il concubinato del marito, solo nel caso in cui lo stesso teneva la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove;
3. art. 544 c.p. sul c.d. matrimonio riparatore (abrogata nel 1981): che prevedeva l’estinzione dei reati di violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine, seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata e corruzione di minorenni (artt. 519-526 e 530), posti in essere nei confronti di una donna, nel caso che lo stupratore accondiscendesse a sposarla, salvando l’onore suo e quello familiare (riconosciuto come un valore socialmente rilevante). Un caso eclatante di ribellione al matrimonio riparatore fu quello di Franca Viola, nel 1947;
4. art. 587 c.p. (più di tutti gli altri articoli tipicamente espressione di una forma di femminicidio!) sul c.d. omicidio a causa d’onore, abrogato solamente nel 1981 ovvero ben 11 anni dopo l’approvazione della legge sul divorzio (l n. 898/1970): che, ipotizzando il corpo della donna come proprietà di un uomo, padre, marito, fratello, considerava meno grave di altre forme di omicidio di diverso movente (sanzionandolo con pene molto attenuate) l’uccisione della moglie, figlia, o sorella, infedeli (o del marito nel caso che ad esser tradita fosse stata la donna, nonché dell’altro protagonista dell’illegittima relazione carnale), qualora il fatto fosse stato commesso dall’autore in preda allo stato d’ira (nella prassi sempre presunto); la stessa attenuazione di pena valeva per le lesioni personali, mentre la norma dichiarava non punibile, in nome di un presunto jus corrigendi, il delitto di percosse commesso nelle medesime circostanze contro le suddette persone;
5. la norma sulla violenza carnale (di chiara ispirazione maschilista): che era inserita, fino al 1996 (quando è stata collocata nel titolo dei delitti contro la persona), tra i delitti contro la morale pubblica e il buon costume, secondo una visione arcaica della violenza sessuale che impediva alla donna di compiere libere scelte in relazione alla propria sessualità.
Va detto che, oggi, quegli stessi elementi che un tempo erano ritenuti rilevanti ai fini dell’attenuazione della pena, in quanto espressione dell’esercizio di un potere dell’uomo sulla donna, sono stati utilizzati, invece, per aggravarla. Nel nostro codice penale, però, non esiste un illecito penale ad hoc per il femminicidio, come sub-fattispecie dell’omicidio, a differenza di quanto previsto dalle legislazioni di alcuni Paesi dell’America Latina, come ad esempio il Cile, in cui è punito come femminicidio l’uccisione di una donna da parte del marito o ex marito o del compagno o ex compagno. Sono presenti, invece, alcune sub-fattispecie di omicidio (aggravate), caratterizzate dal dato, puramente oggettivo, dell’esistenza di un rapporto di matrimonio o di parentela tra autore e vittima del reato (v. uxoricidio, parricidio, fratricidio, ecc…). In questo caso si tratta, però, di figure di omicidio non inclusive della differenza sessuale e non necessariamente legate ad un movente di genere, che sono sanzionate in modo più grave a causa della particolare riprovazione che suscitano nella collettività, in considerazione degli stretti vincoli di parentela e del legame che uniscono autore e vittima del reato e che impongono particolari obblighi di protezione.
Un’altra forma di omicidio, che specifica le particolari caratteristiche della vittima e che costituisce un’autonoma figura di reato (e non un’ipotesi di omicidio aggravato), è l’infanticidio o feticidio (art. 578 c.p.).
Ovviamente il concetto di femminicidio, abbraccia un insieme più ampio di condotte rispetto a quelle sopra indicate, poiché mira a proteggere la donna, vittima della violenza di genere, non solo in ambito familiare, ma all’interno di qualunque rapporto affettivo, anche non formalizzato e, quindi, indipendentemente da qualsiasi vincolo familiare in senso stretto.
Il legislatore italiano, comunque, ha inserito nel codice penale alcune forme aggravate di omicidio (v. l. 38/2009 e 172/2012) che, in qualche modo, esprimono la volontà di dare riconoscimento giuridico al fenomeno del femminicidio. Le nuove fattispecie di omicidio aggravato, “sessualmente neutre”, inserite nel codice penale prima della c.d. legge sul femminicidio, punite con l’ergastolo, si configurano in cinque ipotesi, inserite nell’art. 576 c.p., co. 1, n. 5 e n. 5.1, c.p. di cui le prime tre, sotto elencate, richiamano il movente di genere dell’autore (sia esso uomo o donna):
1. se l’omicidio è connesso al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi;
2. se l’omicidio è commesso in occasione della realizzazione di uno dei delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo);
3. se l’omicidio è commesso da un soggetto che abbia realizzato la condotta di atti persecutori nei confronti della stessa vittima in occasione della perpetrazione;
4. se l’omicidio è commesso in occasione della perpetrazione del delitto di prostituzione minorile;
5. se l’omicidio è commesso in occasione della perpetrazione del delitto pornografia minorile.
Ebbene, per quanto concerne, le prime tre figure di omicidio aggravato, il disvalore aggiuntivo della condotta ed il maggior rigore sanzionatorio, sono giustificati dal fatto che il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza, che integra fattispecie delittuose (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori), che sono tra le più ricorrenti condotte perpetrate dall’uomo sulla donna (o viceversa), spesso prodromiche alla realizzazione di delitti più gravi, che non di rado culminano nell’uccisione della vittima.
Infine, un’altra forma di omicidio per motivi di genere può configurarsi in relazione all’aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 11, c.p. (“l’avere commesso il fatto con abuso … di relazioni domestiche”), nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso da un uomo in danno di una donna o viceversa, approfittando del rapporto sentimentale con la vittima.
Malgrado il Governo, dunque, abbia definito le disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza di genere come “decreto sul femminicidio”, la l. 119/2013 non ha previsto l’inserimento nel codice penale di una fattispecie ad hoc di femminicidio né, tantomeno, ha considerato il femminicidio come una circostanza aggravante, prevedendo un aumento di pena per l’omicidio se realizzato da un uomo in danno di una donna, nell’ambito di un’attuale o pregressa relazione coniugale o affettiva.
In tal senso, va precisato che, la Convenzione di Instanbul, cui si è richiamato il legislatore del 2013, comunque, non imponeva agli Stati di introdurre una fattispecie ad hoc di femminicidio nell’ordinamento interno, nemmeno sotto forma di circostanza aggravante, e che un crimine ad hoc di femminicidio non è previsto nemmeno nel diritto internazionale.
5. Previsione di una fattispecie ad hoc di femminicidio nell’ordinamento penale italiano. Difficoltà di tipizzazione del fatto punibile e violazione del principio di eguaglianza dell’art. 3 della Costituzione.
Nondimeno, va rilevato che la previsione di uno specifico reato di femminicidio presenta alcune difficoltà legate alla tipizzazione del fatto punibile. Infatti, non è semplice, tradurre in una formula ben definita il movente dell’autore (uccisione di una donna a causa della sua condizione di donna) – espresso con una locuzione ampia e non chiara nel suo significato qual è quella di violenza di genere – e, soprattutto, non è semplice provarlo. Ciò in quanto si tratta di un concetto troppo elastico, perciò, suscettibile di diverse interpretazioni, che non permette di definire, accertare e differenziare il “movente di genere” dell’autore del femminicidio rispetto a quello dell’autore dell’omicidio di una donna, per motivi non riconducibili alla violenza di genere.
Ebbene, questi ampi margini di incertezza dei criteri di imputazione oggettiva e soggettiva, della fattispecie che dovrebbe essere incriminata come femminicidio, sembrano incompatibili con il principio garantista di determinatezza dei presupposti della responsabilità penale, stante la difficoltà di formalizzare giuridicamente la categoria del movente di genere in ambito penale, nel rispetto del principio di legalità.
Certo, la previsione di un reato di femminicidio avrebbe un forte impatto nel contesto socio-culturale di riferimento e permetterebbe di stigmatizzare in modo più efficace le frequenti uccisioni di donne legate sentimentalmente al loro aggressore. Tuttavia, tale previsione di una fattispecie autonoma e più grave rispetto a quella di omicidio, in funzione di maggior tutela della donna, a parte le suddette difficoltà di natura legislativa, pone inquietanti interrogativi di natura costituzionale, oltre che di opportunità, in ragione dell’uguaglianza formale del bene vita per l’omicidio dell’uomo e della donna. Infatti, non può considerarsi ragionevole una deroga al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., basata soltanto sul dato che il femminicidio riguarda una categoria di persone che, in passato, hanno subito discriminazioni di ordine sociale e culturale e che, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe discriminazioni. In altre parole, non sembra che il femminicidio, come reato ad hoc, possa trovare giustificazione nel fatto che viene usato come forma di punizione e controllo sociale sulle donne né, tantomeno, che possa trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche della violenza esercitata contro le donne, per la specificità della condizione in cui si sono storicamente ritrovate, in quanto appartenenti al genere femminile. Non è di per sé sufficiente, dunque, la circostanza che il fenomeno della violenza della donna sull’uomo, dal punto di vista quantitativo, sia scarsamente rilevante e, dal punto di vista qualitativo, non sia così grave come nel caso di violenza compiuta dall’uomo sulla donna.
Infine, va rilevato che l’introduzione del femminicidio, come reato a sé stante, dal punto di vista politico-criminale, manca di un solido e ragionevole fondamento che la sostenga. Infatti, tale previsione non sembra trovare giustificazione nell’esistenza di dati che comprovino l’incidenza statistica rilevante di casi di femminicidio ovvero nel fatto che la questione fondamentale sia la violenza maschile sulle donne.
Quanto, invece, al femminicidio, inteso come fenomeno sociale nella sua globalità, con un significato più complesso di omicidio di genere femminile, entro il quale sono riconducibili un’ampia gamma di comportamenti violenti nei confronti della donna, il motivo per cui non è riconosciuto come reato a sé stante, dipende dall’impossibilità di costruirlo come concetto giuridico ovvero di tradurre un fenomeno sociale, storico e culturale, in una fattispecie penale. E’, infatti, del tutto impensabile che un fenomeno come quello del femminicidio, caratterizzato da una forte indeterminatezza di contorni, possa assumere i caratteri di una specifica figura di reato, che comprenda tutte le condotte violente misogine che meriterebbero di rientrare nell’ambito di protezione di tale reato e che, al contempo, sia compatibile con il principio di stretta legalità e tassatività della fattispecie penale. Analogo discorso vale per la costruzione del femminicidio come aggravante di altre figure delittuose.
6. Necessità di azioni di contrasto a livello politico ed istituzionale contro il femminicidio.
Spesso, dietro l’atteggiamento di chi propone un diritto penale della differenza (connotato dal genere femminile come soggetto passivo), che miri a riconoscere alle donne maggiore protezione di quella riconosciuta agli uomini, in relazione ai reati che si collocano nell’area della violenza maschile verso il genere femminile, non solo si nasconde una visione sessista e patriarcale cui, si aderisce consapevolmente o inconsapevolmente, ma si nascondono anche antichi pregiudizi, contraddizioni e luoghi comuni. Infatti, considerare ogni atto di violenza subito da una donna “per essere donna” come lesivo non solo dei beni giuridici individuali che la riguardano, ma anche come lesivo di tutto il genere femminile, sul fondamento di una supposta esperienza e di un comune destino di vittimizzazione, comporta l’idea che le donne, complessivamente considerate (per lo meno dal momento in cui sono legate sentimentalmente al proprio aggressore), si trovino in una posizione di subordinazione all’uomo, non solo nella sfera familiare, ma anche in quella delle relazioni sociali, politiche ed economiche. Comporta, cioè, che le donne si trovino proprio in quella condizione in cui tradizionalmente la cultura maschilista imperante nella società le ha poste e contro la quale hanno duramente combattuto i movimenti femministi.
Tuttavia, non può esserci uguaglianza formale se l’uguaglianza sostanziale viene impedita o limitata da ostacoli di ordine economico e sociale. Perciò, la parità di diritti delle donne si risolve in un’ipocrita finzione se, di fatto, poi, mancano i mezzi per esercitare e assicurare tali diritti. Sarebbe, dunque, necessario prevedere piani d’intervento che, riconoscendo la discrasia tra i diritti garantiti alle donne in linea astratta e la loro reale possibilità di esercitarli, siano idonei a dare ingresso alle istanze di protezione delle donne contro forme persistenti e sistematiche di violenza maschile e di prevenire, così, i fattori di rischio (di tipo sociale, economico, culturale e ambientale), agendo a livello strutturale, cioè sulle cause profonde che costituiscono un terreno fertile per il diffondersi ed il persistere della violenza contro le donne.
E’ in questa prospettiva che vanno lette le raccomandazioni fatte, nel 2011, al nostro Paese dal Comitato CEDAW, che, rilevando le numerose e gravi mancanze imputabili allo Stato italiano nell’adempiere alle obbligazioni internazionali, in materia di discriminazione e violenza nei confronti delle donne, e sottolineando la preoccupazione per l’elevato numero di donne uccise dai propri partner o ex partner, indica la necessità evidente e la possibilità di prevenire tali delitti grazie ad un’azione efficace sulle cause strutturali e profonde che determinano le discriminazioni e la violenza nei confronti delle donne.
Per queste ragioni, è di fondamentale importanza che contro il femminicidio, come problema sociale e culturale, si promuovano azioni di contrasto a livello politico ed istituzionale e che, al diritto penale, invece, si lasci il compito di frammentare tale fenomeno e di ridurlo a singoli fatti aggressivi dai contorni ben definiti.
7. I Centri antiviolenza in Italia.
In Italia i primi Centri antiviolenza sono nati alla fine degli anni novanta, creati da associazioni di donne provenienti dal movimento delle donne, tra cui le Case delle donne per non subire violenza di Bologna e la Casa delle donne maltrattate di Milano.
Oggi le organizzazioni che lavorano sui vari tipi di violenza sono svariate. I Centri antiviolenza in Italia si sono riuniti nella Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne. Nel 2008, inoltre, è nata una federazione nazionale che riunisce 65 Centri antiviolenza in Italia dal nome “D.i.Re. – Donne in Rete contro la violenza”.
D.i.Re. fa parte dell’organizzazione europea WAVE, network Europeo dei Centri antiviolenza, che raccoglie oltre 5.000 associazioni di donne.
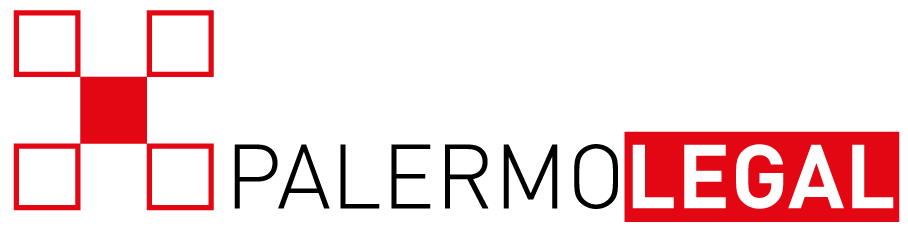




No Comments